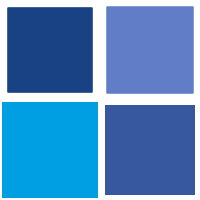Buon senso… vietato?
“Abbiamo già conosciuto l’avversità e ne siamo sempre usciti molto più forti”.
Queste parole avrebbero potuto essere pronunciate da Alexis Tsipras nella foga dell’azione per mobilitare il popolo greco; invece sono state pronunciate per la Storia da Richard Fuld il 10 settembre 2008, cinque giorni prima di dichiarare il fallimento di Lehman Brothers, la banca di cui era ancora presidente…
Il parallelismo tra la fine di Lehman e la situazione attuale della Grecia è così scontato che fa temere il peggio per il nostro contesto economico e finanziario. Ma diciamola tutta: la situazione di fondo è molto diversa e se il fallimento Lehman ha sconvolto per anni l’economia mondiale, il pianeta finanziario non teme il default della Grecia più di quanto non faccia paura quello annunciato di recente da Porto Rico. Le interazioni nell’economia mondiale sono limitate e i mercati finanziari mantengono la calma di fronte a una situazione che sanno essere inquadrata dalle banche centrali.
Quello che maggiormente ci colpisce, in questi momenti convulsi, è constatare fino a che punto il buon senso e la visione dell’interesse collettivo siano virtù poco condivise! In un mondo informato, istruito e memore dei passati insuccessi, la ragione dovrebbe prevalere e condurre ad adottare decisioni che risultino accettabili per i più.
Ma non è così: molte decisioni sono influenzate unicamente dalla dottrina, le prese di posizione o la debolezza di coloro che sono designati ad adottarle.
L’esempio del regime previdenziale francese illustra a meraviglia questa propensione a dimenticare l’obiettivo comune. I regimi nati in tutta Europa dopo la Seconda Guerra mondiale hanno come fondamento la solidarietà intergenerazionale e la ripartizione garantita dallo Stato. Un sistema concepito in maniera formidabile, ma che ha dovuto fare i conti con l’evoluzione delle nostre società: il calo della natalità, l’allungamento della vita media e il fenomeno della disoccupazione di massa hanno rapidamente rimesso in discussione l’economia delle nostre pensioni.
Queste evoluzioni sfavorevoli hanno obbligato numerosi Stati a modificare il proprio regime pensionistico. I più previdenti (Regno Unito, Cile) hanno provveduto già negli anni ’70, seguiti negli anni ’90 da Svezia, Germania, Nuova Zelanda… Anche l’Italia ha previsto negli anni ’90 una profonda modifica del suo sistema previdenziale calcolando modifiche scaglionate su… 40 anni!
In Francia, dove l’età della pensione à stata abbassata a 60 anni nel 1982, non è stata ancora avviata nessuna riforma di fondo. Eppure, la spesa complessiva per le pensioni ammonta oggi a 294 miliardi di euro, l’equivalente degli introiti fiscali lordi complessivi percepiti dallo Stato nel 2014. Le varie relazioni che si susseguono e le diverse commissioni incaricate di studiare l’argomento si limitano a constatare, mettere in guardia e colmare le falle di un sistema che dal 2005 genera un deficit permanente (più di 9 miliardi di euro nel 2014).
Da 20 anni, in Francia la riflessione si blocca sull’aumento dell’età pensionabile e sugli anni di contributi, per poi passare il testimone ai “decisori” successivi, senza mai preoccuparsi di una fondamentale ridefinizione del sistema previdenziale.
Ironia della storia, tutta l’Europa reclama oggi alla Grecia una riforma del suo regime previdenziale che consuma il 14% del PIL ellenico, un livello giudicato ampiamente eccessivo… equivalente a quello della Francia!
Se fosse ancora necessario convincere dell’improcrastinabilità delle riforme coloro che detengono la responsabilità decisionale, due dati dovrebbero bastare per richiamare il buon senso sul tavolo dei negoziati: il 92% della popolazione francese è preoccupata per il futuro del sistema previdenziale francese e i due terzi dei pensionati dichiara di non vivere in maniera dignitosa.
E se Alexis Tsipras non avesse del tutto torto nel chiedere l’opinione dei diretti interessati prima di prendere decisioni fondamentali per il loro futuro?
Didier Le Menestrel